Pandemia: un segno dei tempi?
- 21 mag 2020
- Tempo di lettura: 11 min
di Luigi Razzano

Vorrei introdurvi in questo articolo con un brano tratto dagli Atti degli Apostoli (cf. At 8, 26-40), che a mio avviso offre degli spunti riflessivi per creare quei presupposti che possono aiutarci ad interpretare teologicamente questo drammatico evento pandemico e al contempo, ad avere la possibilità di vivere questa circostanza di crisi come un’opportunità evangelizzativa. L’episodio in questione fa luce sulla diffusione della fede cristiana, grazie alla predicazione degli Apostoli, in particolare di Filippo – uno dei sette diaconi scelti dagli Apostoli dopo la Pentecoste per presiedere al servizio dei poveri e delle vedove – colto nel momento in cui annuncia il vangelo ad un Etiope, eunuco, amministratore di tutti i beni di Candace, regina di Etiopia. Si tratta di un avvenimento particolare, perché descrive un segnale di apertura della fede cristiana, oltre i confini del territorio giudaico. L’Etiope, infatti, è uno dei primi non ebrei convertiti al cristianesimo. Il libro degli Atti non ci dice il suo nome, ma solo lo stato civile e il relativo ruolo che svolgeva presso la corte regale. Secondo qualcuno, le caratteristiche che tratteggiano il suo profilo fisico prestano il fianco ad interpretazioni culturali attuali piuttosto ambigue, alle quali però il testo evangelico non fa alcuna allusione, e sulle quali neppure io preferisco soffermarmi, per non suscitare discussioni spinose che necessitano di un adeguato contesto.
Mi piace invece evidenziare due aspetti che danno ragione del presente articolo. Il primo è l’apertura spirituale dell’eunuco che lascia intendere la ricerca di chi non pago della vita che conduce, ha il coraggio di gettare lo sguardo oltre il prestigio e il benessere sociale procuratogli dal proprio ruolo. Egli diventa così simbolo di quanti, anche oggi, vanno alla ricerca di Dio, nonostante godano di varie forme di benessere. Non mi riferisco a quegli intellettuali neutrali dei salotti culturali attuali, che fanno della ricerca una sorta di status simbol, finalizzata a se stesso, quei cercatori di relativismo esistenziale, preoccupati di rimanere sempre al di sopra delle parti, senza mai pronunciarsi, schierarsi per una verità. Al contrario egli è tra quelli che si distinguono per onestà spirituale. La sua capacità di chiedere il battesimo non appena gli viene dischiusa la verità, è emblematica.
Il secondo aspetto è l’apertura mentale e intellettuale che caratterizza l’azione evangelizzativa di Filippo, una qualità piuttosto rara nell’attuale panorama culturale-missionario della Chiesa. Il libro degli Atti lo ritrae nel momento in cui si accosta all’eunuco che sta leggendo un testo veterotestamentario, precisamente il passo del profeta Isaia (cf. Is 53, 7-12). È interessante notare l’atteggiamento – per altro ben evidenziato da Luca – col quale egli si lascia guidare dallo Spirito nelle sue scelte e decisioni (cf. At 8, 26s.29s). Tale atteggiamento ci interpella fortemente perché sferza senza possibilità di giustificazione, la modalità con cui noi, molto spesso, progettiamo le nostre strategie missionarie, guidate più dall’io – dal nostro saper fare - che dallo Spirito di Dio. Egli dunque sotto la spinta dello Spirito si accosta all’eunuco, al quale pone una domanda che ci porta diritti al cuore della nostra riflessione: “Capisci quello che stai leggendo?” (v. 30). “E come potrei se nessuno mi istruisce?”(v. 31), risponde l’eunuco, invitandolo a sedersi sul carro e a farsi spiegare il significato del brano che stava leggendo.
Questo brevissimo dialogo fa luce, in maniera critica, su una situazione paradossale, determinata dal modo con cui una fascia considerevole di cristiani vive la fede nell’attuale contesto socio-culturale. Potremmo definire la situazione in termini di ‘religiosità immanentista’, che consiste nel professare la fede nella vita eterna, ma si vive quella presente secondo una logica immanente, che di fatto contraddice quella evangelica. Provo a spiegare quanto sto cercando di dire immaginando Filippo accostarsi a noi, nell’oggi della nostra fede, e riformulare, adattandola, la stessa domanda posta all’eunuco: “Capisci il senso di questo particolare avvenimento che stai vivendo?”. A tale domanda anche noi potremmo dare una risposta simile a quella dell’eunuco: “E come potrei se nessuno mi insegna i criteri con cui interpretarlo?”. Già, quali sono i criteri con cui interpretare questo particolare evento pandemico? Per rispondere a questa domanda vorrei rifarmi ad un brano di Benedetto XVI, tratto dal suo libro: Gesù di Nazareth (pp. 50-51) che ci apre lo sguardo su un panorama culturale piuttosto drammatico:
“Qui appare chiaro il nocciolo di ogni tentazione: rimuovere Dio, che di fronte a tutto ciò che nella nostra vita appare più urgente sembra secondario, se non superfluo e fastidioso. Mettere ordine da soli nel mondo, senza Dio, contare soltanto sulle proprie capacità, riconoscere come vere solo le realtà politiche e materiali e lasciare da parte Dio come illusione, è la tentazione che ci minaccia in molteplici forme. Della natura della tentazione fa parte la sua apparenza morale: non ci invita direttamente a compiere il male, sarebbe troppo rozzo. Fa finta di indicarci il meglio: abbandonare finalmente le illusioni e impiegare efficacemente le nostre forze per migliorare il mondo. Si presenta, inoltre, sotto la pretesa del vero realismo. Il reale è ciò che si constata: potere e pane. A confronto le cose di Dio appaiono irreali, un mondo secondario di cui non c’è veramente bisogno. È in gioco Dio: è vero o no che Lui è il reale, la realtà stessa? È Lui il Buono o dobbiamo inventare noi stessi ciò che è buono? La questione di Dio è la questione fondamentale, che ci conduce al bivio dell’esistenza umana”.
È chiaro che la situazione descritta dal papa si riferisce ad una società laicista che cerca di rimuovere dalla memoria collettiva e storica la dimensione religiosa, ma non si può escludere che essa faccia luce anche sulla situazione di molti cristiani. Non sono pochi a vivere la propria vita come se Dio non ci fosse. Una sorta di ateismo pratico che di fatto impedisce qualsiasi lettura trascendente della vita. Da qui la difficoltà a rileggere l’attuale situazione pandemica come un ‘segno dei tempi’. Una categoria, questa, necessaria per acquisire quella disposizione interiore che consente di interpretare la storia dall’Altro, da Dio. Essa affonda le sue radici nel movimento profetico e come tale richiede di una prospettiva biblica per essere compresa nel suo significato originario. Essa infatti educa ad interpretare gli eventi storici come ‘cifre’ o ‘luoghi di senso’, che trascendono il dato empirico, il cui significato può essere compreso all’interno di un intimo e profondo rapporto con Dio, quale condizione per cogliere anche i più piccoli segni attraverso i quali Dio può manifestare la sua volontà. Da qui la proposta di alcuni atteggiamenti, che rivolgo a coloro che si ritengono i piccoli del mondo o a quelli che il Vangelo definisce “miti”, ai quali, come dice Gesù, è destinata l’eredità della terra (cf. Mt 5, 5; Sal 36, 11).
Tra questi suggerimenti mi piace menzionare il “fare memoria”, che è un’operazione fondamentale per cogliere il significato autentico di un evento in chiave teologica. Luca esplicita la necessità di questa operazione soprattutto quando tratteggia il metodo evangelizzativo di Filippo e precisamente quando questi viene interpellato dalla domanda di senso postagli dall’eunuco: “Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?” (At 8, 34). È interessante notare che Luca nel tratteggiare la risposta di Filippo, delinea lo stesso metodo evangelizzativo di Gesù, descritto nel brano dei Due discepoli di Emmaus: “E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24, 27). Anche in questo caso notiamo che Filippo prendendo spunto “da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù” (At 8, 35). Il fare memoria è un aspetto che ritorna spesso nella metodologia evangelizzativa lucana. Basta considerare che anche a Pietro fa compiere la stessa operazione nel giorno di Pentecoste (cf. At 2, 14-34), o nel tempio dopo la guarigione dello storpio (cf. At , 11-26), nella casa di Cornelio (At 10, 34-43), o ancora nel caso della controversia sulla circoncisione (cf. At 15, 7-12); a Stefano, dinanzi al sinedrio (cf. At 7, 1-54); a Giacomo, in merito alla predicazione ai gentili (cf. At 15, 13-21); a Paolo, nell’Areòpago di Atene (cf. At 17, 22-34). La sua funzione è quella di mettere in luce il filo conduttore del piano salvifico di Dio tutte le volte che viene smarrito nel labirinto degli eventi storici.
Tale metodo consiste nell’evangelizzare spiegando la Scrittura, considerandola come chiave di lettura per comprendere il senso della storia. Spiegandola si educa a fare memoria degli eventi, così da giungere ad uno sguardo unitario, che è essenzialmente quello con cui Dio guarda il mondo. È importante questa operazione. Spiegare e ricordare significano coinvolgere l’interlocutore all’interno di un discorso che all’inizio appare enigmatico, ma che si dischiude gradualmente alla sua intelligenza grazie al filo conduttore che l’evangelizzatore pone all’attenzione del suo sguardo spirituale, in virtù del quale l’interlocutore ha modo di cogliere la continuità degli eventi storici tra loro e quindi lo svelarsi dell’identità divina di Gesù. Solo quando ci si sente coinvolti all’interno del disegno salvifico dischiuso da Gesù si giunge a scoprire il senso della propria esistenza e, quindi, a chiederne la partecipazione attraverso il battesimo, esattamente come fa l’eunuco. Spiegare e ricordare sono perciò atti sincronici, complementari e fondamentali nel processo evangelizzativo. Essi sono tipici dello Spirito, come attesta Gesù: “Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto” (Gv 14, 26). Lasciandosi guidare dallo Spirito si diventa esegeti degli eventi salvifici di Dio. Ben lontano dunque da quell’atteggiamento che solitamente assumiamo nelle nostre catechesi, dove trasformiamo la nostra pseudo evangelizzazione in un’operazione essenzialmente cerebrale che suscita al massimo un assenso nozionale, lungi dal far ardere il cuore nel petto (cf. Lc 24, 32), riducendo la fede ad una dottrina gnostica. Gesù e Filippo invece fanno scaturire l’atto dello spiegare e del fare memoria da un vissuto evangelico, che a sua volta diventa la luce che illumina dall’interno l’intelligenza a capire e la ragione ad esplicitare il senso. La difficoltà a fare memoria, nel nostro contesto culturale, nasce dalla fatica che facciamo nel quotidiano a vivere e ancor più a rileggere la storia personale, ecclesiale e sociale nel quadro del piano salvifico di Dio. Tale difficoltà, a mio avviso, rivela quel gap intellettivo che ci impedisce di uscire fuori dal presentismo e immanentismo, nel quale abbiamo relegato tutta la nostra esistenza e di giungere a porre la domanda, come nel caso dell’eunuco. Il presente, in realtà, è solo un frammento che va necessariamente ricongiunto al passato e al futuro. È a queste condizioni che possiamo imparare a ricollocare la nostra storia nel vasto orizzonte della storia di Dio. Si rivelano pertanto determinanti quei luoghi ecclesiali che fanno da presupposto ermeneutico per ogni spiegazione teologica della storia, fuori dai quali tali interpretazioni possono apparire incomprensibili.
L’altro atteggiamento dal quale, però, vorrei invitare il lettore a guardarsi è la tentazione di ritornare al passato, specie quando i ‘segni dei tempi’ appaiono incerti e confusi. Si tratta di una tentazione che sta sempre in agguato. Per esplicitarla mi piace qui riferirmi alla storia del popolo d’Israele, più precisamente all’esperienza esodale. Anche il popolo d’Israele, pur avviato al cammino della libertà, avverte sempre forte l’idea di ritornare in Egitto, a testimonianza di quanto molto spesso si preferisca una schiavitù che offre serenità e sicurezza sociale, ad una libertà che espone al rischio della precarietà esistenziale e spirituale. Contrariamente a quello che una certa cultura liberale ha voluto farci intendere, la libertà è una condizione esistenziale molto più impegnativa, rispetto a quella che la fa determinare da una conquista intellettuale o da un benessere economico, sociale e psicofisico. Essa comporta la necessità di entrare nella logica del rinnegamento che Gesù chiede a chiunque decide di mettersi alla sua sequela (cf. Mt 17, 1-8; Lc 9, 28-36; Mc 8, 38). Non a caso Luca fa leggere all’eunuco un carme del servo sofferente, autentica chiave di lettura per capire l’opera redentiva di Cristo, una condizione non facile da comprendere, ancor meno da vivere. Perfino gli apostoli si sono spaventati davanti a quella esposta loro da Gesù. Lo aveva fatto già Pietro quando a seguito della sua intuizione cristologica a Cesarea di Filippo, aveva cercato di distogliere Gesù dalla necessità della sua passione (cf. Lc 9, 22; 9, 44; 18, 31-33 e //). Su questa necessità Gesù ritorna anche dopo la sua risurrezione, mentre conversa con i due discepoli di Emmaus: “Non bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?” (Lc 24, 26). Essa costituisce una via imprescindibile, che ci inchioda nella nostra responsabilità, senza possibilità di evasione. Il fare memoria della storia pertanto non è semplicemente ricordare il passato, ma ciò che biblicamente viene formulato in termini di ‘Shemà Israel’: ricorda quanto Dio ha operato per te, mentre ti liberava dalla tua schiavitù. Fare memoria significa inoltre individuare quel filo conduttore attraverso il quale lo Spirito di Dio, in un modo sia pure misterioso, guida la storia, grazie a coloro che come Filippo si mostrano docili al suo intervento e si lasciano illuminare la mente e il cuore nelle scelte di vita.
Potremmo, dunque, benissimo rileggere la situazione attuale alla luce della Parabola del figlio prodigo (cf. Lc 15, 11-32), ripercorrendo il cammino del figlio più giovane quando, rientrando in se stesso, comincia a fare memoria della sua storia. Lì avverte più che mai di recuperare quell’atteggiamento che anche noi cristiani abbiamo quasi smarrito: la filialità. Essa è il primo passo verso il ritorno del padre. Questo recupero però necessita di una condizione fondamentale a qualsiasi cammino spirituale: l’umiltà. L’umiltà è la condizione per cominciare ad ammettere i propri errori: “I nostri padri, in Egitto, / non compresero le tue meraviglie, / non si ricordarono della grandezza del tuo amore / e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso” (Sal 106,7). Nella solitudine, come quella che abbiamo avuto modo di sperimentare in questo periodo, i ricordi riaffiorano come polle d’aria dagli abissi della coscienza. Il raccontare plasma nella nostra memoria la presenza di Dio. In questo memoriale Dio smette di essere un ricordo astratto e diventa presenza viva, vivificante e liberante. Il memoriale non è solo il ricordo di un fatto avvenuto nel passato, ma di un evento che continua a vivere nel presente, che mantiene ancora vive le dinamiche del suo accadere nella storia. Più che guardare al passato la memoria di Dio ci invita a guardare avanti, leggendo nel presente, nel vissuto della nostra vita, i segni del suo sviluppo e progresso. È un memoriale fatto di metafore e simboli che dischiudono i propri significati l’uno nell’altro, esattamente come le relazioni della nostra vita. “Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi” (Dt 8,2). Dio stesso muove il nostro ricordo di lui: “Allora mi ricordai della tua misericordia, Signore, e dei tuoi benefici da sempre, perché tu liberi quelli che sperano in te e li salvi dalla mano dei nemici” (Sir 51,8). È un ricordo che suscita la supplica, l’implorazione, la preghiera: “Ricordati di me, Signore, per amore del tuo popolo, vieni a visitarmi con la tua salvezza” (Sal 106,4).
Quando il cuore è pronto accade l’abbraccio, un abbraccio pasquale perché fa compiere il passaggio da servo a figlio. Il padre investe il figlio della sua paternità. Lo avvolge, lo copre con la sua misericordia. “L’amore copre una moltitudine di peccati”, dice Pietro nella sua lettera (1Pt 4, 8). L’amore diventa luce per la sua mente, che finalmente gli fa conoscere la verità di sé e la verità del padre. L’abbraccio con cui egli avvolge il figlio è un abbraccio pasquale, nel senso che fa compiere al figlio il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla redenzione: “Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte (1Gv 3,14). È un abbraccio trasfigurante e liberante, che fa compiere al figlio il rinnegamento del proprio io e il riconoscimento della paternità del padre, che compie la redenzione dalla propria mentalità autorealizzativa e autoredentiva. Non annulla la volontà umana, ma la trasfigura. Ecco lo specifico del nostro atteggiamento in questo particolare momento storico: Dio non ci chiede di cancellare la nostra storia, ma di rivederla dall’interno alla luce del suo amore redentivo. Si delinea così il grande compito formativo che noi cristiani siamo chiamati a svolgere dall’interno del nostro tessuto sociale: educare le coscienze a rileggere la storia nella prospettiva di Dio. Non si tratta di fare apologia e neppure di chiedere un diritto di libertà religiosa, ma di essere persuasivi e credibili così da mettere chiunque nella condizione di poter dare ragione della speranza che è in ciascuno (cf. 1 Pt 3, 15). Si tratta di tradurre a livello spirituale quello che A. Einstein riteneva fondamentale per la risoluzione dei nuovi problemi sociali: “Non è possibile pretendere di risolvere problemi con la stessa mentalità che li ha creati”. La questione in gioco non è appena un benessere sociale, al quale tendere nel nostro futuro, ma il senso stesso della salvezza, della quale neppure noi cristiani parliamo più, tesi come siamo a conquistare solo quella terrena. Più che mai ritorna il monito di Gesù: “A che giova guadagnare il mondo intero, se poi perdiamo l’anima?” (cf. Mc 8, 36). L’eunuco e Filippo diventano allora i simboli di quella onestà spirituale ed intellettuale, di cui oggi abbiamo fortemente bisogno, se vogliamo veramente dare una svolta esistenziale alla nostra vita. Essi traducono a livello evangelico quell’esigenza che U. Saba percepiva a livello culturale: “Ai poeti resta da fare la poesia onesta”.


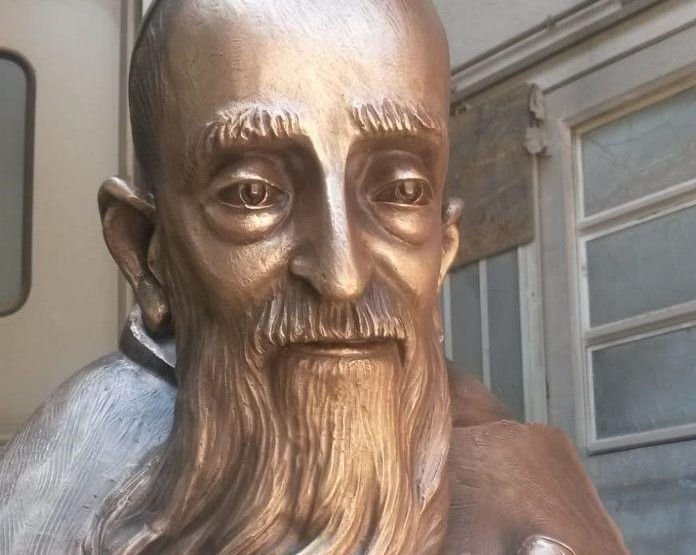

Commenti