L’Europa e la fede in Cristo: nel delicato passaggio dalla prima alla seconda chiamata
- don luigi
- 28 apr 2020
- Tempo di lettura: 12 min
Aggiornamento: 29 apr 2020
di Luigi Razzano
Il tema piuttosto impegnativo esposto nel titolo richiede senza dubbio una fatica notevole per chi volesse accingersi a trattarlo sotto il profilo storico, col rischio di tediare anche il lettore più interessato.

Da qui l’idea di affrontarlo sotto l’aspetto biblico. Non che questo sia meno impegnativo, tutt’altro, ma esso ci consente di esplicitare quella ragione spirituale che molto spesso, pur rimanendo tacita dentro di noi - per via dei diversi condizionamenti culturali - , permette di dare un senso al vissuto quotidiano, specie quando questo diventa particolarmente difficile a livello esistenziale. Il contesto storico, culturale, sociale e spirituale nel quale, come Europa, ci ritroviamo è certamente un tempo che necessita di una profonda interpretazione profetica, ancor più se collocato nel quadro del passaggio epocale in cui esso sta accadendo. Non escludo, anzi direi che sono stato sollecitato ad offrire questa prospettiva anche dal tentativo di cogliere il senso di questo straordinario evento pandemico, che sembra costituire non solo un ulteriore segnale di crisi, ma addirittura il capolinea del sistema occidentale della vita. Una prospettiva non facile da registrare e tantomeno da esplicitare, se non all’interno di un orizzonte di fede, che mi sforzerò, per quanto è possibile, di tracciare nell’arco di questo breve articolo.
In realtà il capolinea può essere interpretato in un duplice modo: uno è quello appena descritto, ovvero come epilogo di un percorso culturale; l’altro è quello che ce lo fa intendere come l’inizio di un nuovo itinerario esistenziale che, però, per essere attuato necessita di una rinnovata visione di vita. È proprio all’interno di questa seconda prospettiva che intendo muovermi. Con la visione occidentale della vita è entrata in crisi anche l’esperienza religiosa che in diversi gradi, modi e forme ha caratterizzato la vita europea in questi secoli. Una crisi, quella religiosa che potremmo qualificare con la categoria di ‘segno dei tempi’, in quanto caratterizzata da quei presupposti spirituali che lasciano intendere le condizioni di una seconda chiamata. Un’interpretazione azzardata per qualcuno, ma che non escluderei a priori. Naturalmente una simile formulazione è plausibile solo alla luce di una prima chiamata, avvenuta agli albori del cristianesimo. Al lettore che in questo momento si sta ponendo la domanda sul significato di prima e seconda chiamata, chiedo la pazienza di inoltrarsi nello sviluppo che segue.
Una chiamata, dunque, la seconda che cercherò di esplicitare commentando il brano evangelico di Giovanni 1, 35-51. È evidente che si tratta di una lettura spirituale, nella quale mi sforzerò di esplicitare alcune intuizioni ispirative, provenienti dal brano. Con ciò non intendo mettere da parte la prospettiva storica. Al contrario, essa fa da sfondo, col suo vissuto quotidiano, sul quale è importante lasciar posare quel fascio di luce, proveniente dalla lettura biblica, che può illuminarla dal di dentro. Per rendere più scorrevole la lettura ed evitarvi lo sforzo di andare a cercare il testo nella Bibbia, vi propongo qui di seguito il brano:
“Il giorno dopo Giovanni stava ancora (là) con due dei suoi discepoli e, fissato Gesù che camminava, disse: Ecco l’agnello di Dio! E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse loro: Che cercate? Gli dissero: Rabbì - che tradotto significa maestro -, dove dimori? Disse loro: Venite e vedrete! Vennero dunque e videro dove dimorava e si fermarono presso di lui quel giorno. Era circa l’ora decima” (Gv 1, 35-39).
In verità sarebbe opportuno leggere il brano già a partire dal versetto 19 – anzi, vi invito a farlo prima di proseguire nella lettura dell’articolo – perché esso ci dà modo di ricostruire lo sfondo religioso e culturale sul quale si pone il passaggio spirituale segnalato dal titolo. L’opera compiuta dal Battista tratteggia, per certi versi, il profilo della tradizione religiosa nella quale l’Europa ha, per così dire, creato i presupposti dei suoi natali culturali, religiosi e spirituali. In questa prospettiva la cristianità sembrava dovesse costituire il progetto sociale che traduceva nella realtà terrena la misteriosa realtà del Regno di Dio, di cui parla Gesù in diverse circostanze della sua predicazione. Un progetto quello terreno, che al di là della sacra intenzione che lo ha determinato, si è rivelato, senza dubbio, più politico che religioso, ragion per cui, nel corso della storia, ha dovuto far fronte a tutti i limiti che ne hanno decretato la fine. Così i presupposti critici, che erano presenti in embrione sin dall’inizio, sono definitivamente esplosi con l’avvento della modernità (sec. XV) e del modernismo (sec XIX), manifestandosi per quello che effettivamente erano. Il nichilismo ha praticamente reso noto il loro volto autentico, sancendo al contempo non solo la fine della cristianità, ma decretando anche la morte di un’immagine di Dio e della relativa visione religiosa. In questo processo storico-culturale non sono mancate manifestazioni di autentica vita ecclesiale, spirituale ed evangelica, così come non sono mancate occasioni per porre alla Chiesa domande come quelle rivolte al Battista: “Tu chi sei?” (cf. Gv 1, 19-22), come a volerne sollecitare una chiara esplicitazione identitaria. La Chiesa, da parte sua, ha formulato la risposta in modo limpido ed evidente, non senza difficoltà, in alcuni documenti magisteriali del Vaticano II, come le costituzioni: Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosantum Concilium, Gaudium et Spes, attraverso le quali essa ha , per così dire, tradotto nell’oggi della fede e della cultura, la stessa risposta che il Battista dà ai suoi interlocutori: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore” (Gv 1, 23). Nel compiere questa operazione la Chiesa ha non solo ridisegnato il profilo della sua identità, sulla base della fedeltà alla tradizione evangelica viva ed operante nella storia, ma ha saputo, con coraggio, rinnovare lo stesso annuncio di fede del Battista, indicando il Cristo come “l’Agnello che toglie i peccati del mondo” (v. 29) a ciascun uomo e donna, nell’oggi culturale di ogni epoca storica. È proprio sulla base di questo annuncio che intendo innestare l’istanza della ‘seconda chiamata’.
Essa dunque presuppone un retroterra storico-spirituale, senza il quale il passaggio, a cui essa fa riferimento, diventerebbe praticamente incomprensibile. Pertanto è importante saper fare memoria di quel filo conduttore che nel corso della storia ha progressivamente messo l’Europa e gli Europei nella condizione di dischiudere creativamente, sia pure nella diversità culturale, l’identità religiosa e spirituale. Una simile operazione risulta quanto mai fondamentale, se s’intende cogliere il senso verso il quale riorientare e risignificare la propria esistenza, proprio in un momento storico come il nostro, dove si avverte, più che mai impellente, l’esigenza di andare oltre il relativismo e lo scetticismo che caratterizza gran parte della cultura attuale. Che lo si ammetta o meno, all’origine della nostra realtà culturale c’è un’esperienza di fede; un dato ineludibile che può essere contestato solo con la disonestà intellettuale e spirituale. Un’esperienza spirituale, dunque, quella cristiana ed ecclesiale che si è storicizzata attraverso la testimonianza di quanti, come il Battista, hanno avuto il coraggio di riconoscere in Gesù il Cristo, per il quale hanno dato persino la vita, come attestano i numerosi martiri che ancora oggi abbondano. Costoro hanno come tracciato un percorso storico, lungo il quale hanno disteso e dischiuso, nelle varie stagioni culturali e spirituali, il Volto di Cristo, dando ragione della sua identità divina. Si tratta di un cammino storico-mistico che ha segnato, come pietre miliari, la nostra fede in un vissuto spirituale, ecclesiale e sociale. Così il Battista, in qualità di testimone, si è, per così dire, ripetutamente ‘incarnato’ lungo la storia, nelle varie figure profetiche che ci hanno insegnato a riconoscere Cristo nella nostra vita. Non è stato sempre facile, non lo è neppure tuttora, nonostante la nostra esperienza di lui. Anche il Battista ha faticato a riconoscerlo, come onestamente ammette: “Io non lo conoscevo” (Gv 1, 31.33). Lui ha perfino dubitato dinanzi al modo con cui Gesù rivelava la sua messianicità: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?” (Mt 11, 3). La sua visione profetica tuttavia, come quella di coloro che ci hanno preceduto, si è rivelata decisiva. Da loro abbiamo imparato a capire i criteri con cui riconoscerlo tra le voci di quelli che invece con le loro ideologie filosofiche, teorie scientifiche e visioni artistiche e letterarie hanno ammaliato intere generazioni, dando origine a non poche visioni di vita, rivelatesi profonde delusioni e sfociate in veri e propri drammi esistenziali. - Basti ricordare l’idealismo, il nichilismo, il marxismo tra le cause che hanno determinato l’insorgere dei tragici fenomeni dei campi di concentramento -. Tali criteri ci hanno educato a vedere dall’Alto e dall’Altro la nostra vita, esattamente come ha fatto Giovanni con coloro che aderivano al suo battesimo. Grazie a questi criteri abbiamo imparato a cogliere il modo con cui Dio dischiude il suo disegno salvifico nella storia. In altre parole anche noi, come Giovanni, per riconoscere Gesù tra la folla, abbiamo avuto bisogno dello Spirito che ci ha fornito quello sguardo e fatto acquisire quella mentalità che ci ha permesso di iniziare, nel nostro vissuto quotidiano, quel processo di conversione di fede che abbiamo saputo mantenere inalterato, vivo e vero, lungo la prolungata tradizione ecclesiale che ci ha preceduto. Tuttavia, benché la storia europea sia stata costellata di santi e sante che hanno saputo costantemente rispondere alle istanze spirituali e culturali di ogni epoca storica, ora ci si ritrova a vivere una crisi spirituale, dalla quale non sembra affatto facile uscirne. Ecco allora il duplice significato di epilogo che è opportuno ricordare: mentre da una parte la fede sembra aver perso quel mordente carismatico con cui si è sempre contraddistinta nella storia, dall’altra proprio questa particolare crisi sembra volerci suggerire i presupposti per una vera e propria svolta spirituale. Tale svolta può essere formulata, come dicevo, in termine di seconda chiamata, grazie alla quale diventa possibile riprendere le fila del discorso spirituale, interrotto a partire dalla modernità. Un processo non certo lineare e limpido, per i numerosi risvolti e implicazioni culturali, politiche, sociali che esso ha comportato e comporta. Al contrario fortemente caratterizzato da segnali contrastanti che danno adito a interpretazioni contraddittorie tra loro. D’altra parte è anche vero che quella che sto cercando di esplicitare è un’intuizione che può essere colta solo da coloro che vivono in modo spirituale questa particolare fase storica europea. Si tratta dunque di una fase in cui siamo chiamati al passaggio del testimone: solo che mentre di solito questo avviene da una generazione all’altra, in questo momento esso sta avvenendo da un’epoca storica e l’altra. Un passaggio, quindi, così grande e coinvolgente che a stento riusciamo a oggettivare e a comprenderne le proporzioni. Per questa ragione esso necessita di una maggiore radicalità evangelica, comprensibile solo alla luce di una più profonda esigenza di comunione d’amore con Cristo.
Il Battista esprime tutto questo quando capisce che è giunto, nella sua vita, il momento di indicare Gesù ai suoi discepoli, come il Cristo che d’ora in poi dovranno seguire (cf. Gv 1, 36). Tra i discepoli non tutti accolsero il suo annuncio. Solo Andrea e Giovanni ebbero il coraggio di staccarsi dalla sua tradizione religiosa e spirituale, per aderire a quella che si andava dispiegando, in modo del tutto nuova, davanti ai loro occhi, attraverso il Cristo. Cristo si rivela loro come colui che apre l’intelligenza a cogliere il filo conduttore di quella esperienza di fede che , originatasi col Battista, si avviava ora verso il suo compimento. L’ascolto della Parola li porta a maturare la decisione di lasciare Giovanni e seguire Gesù. Ecco il momento determinante e decisivo, che opera la svolta definitiva nella vita dei questi due discepoli, svolta che traccia profeticamente la parabola del nostro itinerario spirituale, nell’oggi della nostra fede e che ciascuno è chiamato ad attuare a secondo del proprio livello spirituale e stato di vita. Anche noi, come Giovanni e Andrea, possiamo procedere nel nostro cammino di fede solo se mossi dall’amore e da quel desiderio di comunione al quale Cristo ci invita. In questo orizzonte una simile svolta di fede diventa praticamente incomprensibile e inattuabile, se si rimane ancorati alla visione precettistica della religione. Se c’è una ragione dunque che consente ai due discepoli la sequela del Cristo, questa è certamente quella di aver colto in lui la possibilità di una relazione personale viva e vera. Cristo si rivela loro come colui che consente il passaggio dall’antico al nuovo modo di pensare e relazionarsi con Dio, una relazione che Gesù formula in termini filiali, che consente loro di scoprire Dio come Padre. La riscoperta della paternità divina è il vero processo di conversione a cui siamo chiamati in questo particolare momento storico della nostra vita.
L’incontro dei due discepoli con Gesù provoca una domanda: “Che cercate?” e una contro domanda dei discepoli: “Maestro dove abiti?” (Gv 1, 38). Queste due domande si rivelano particolarmente significative per verificare il livello del nostro rapporto con Gesù e ci invitano a scendere ancora più in profondità nel nostro cammino di fede. Ci saremmo aspettati che Gesù chiedesse: “Chi cercate?” e invece chiede: “Che cosa cercate?”. In realtà anche noi, come i due discepoli del Battista, non abbiamo più bisogno di sapere chi è Gesù sotto il profilo dottrinale. Il nostro incontro con lui è già avvenuto: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret” (Gv 1, 45), già all’inizio del nostro cammino di fede. Lo abbiamo conosciuto attraverso tanti modi che hanno caratterizzato il nostro cammino formativo: il catechismo, la vita pastorale negli ambienti religiosi, per alcuni gli studi di teologia, gli incontri e gli Esercizi Spirituali. Abbiamo imparato molte cose di lui. Ora avvertiamo una maggiore esigenza. Non ci basta sapere più chi egli sia, ma avvertiamo l’esigenza di comunicarlo e per farlo occorre – come afferma il Card. J.H. Newman – passare dall’assenso nozionale all’assenso reale. Un passaggio che necessita di “stare con lui” (cf. Mc 3, 14), abitare nella sua stessa casa, partecipare della sua stessa vita. Ecco la vera conversione intellettuale e spirituale che siamo chiamati ad attuare.
Proviamo ora per un attimo a calarci nei panni di questi due discepoli e a rispondere ad alcune possibili domande che Gesù potrebbe farci, oggi: Cosa cerchi? Cos’è che vuoi veramente nella vita? Dove stai orientando la tua ricerca? Da chi attendi una risposta? Chi potrà dare senso e compimento alle tue domande? Se tu fossi stato al posto dei due discepoli ti saresti lasciato coinvolgere dalla rinnovata visione di Dio, propostati da Cristo? Avresti avuto il coraggio di acquisire la sua nuova mentalità religiosa? Forse questi interrogativi ci porteranno a dover fare delle scelte, magari anche radicali, a lasciare quel modo tradizionale, abitudinario, generico, vago, di vivere la fede e cercare Dio, ed essere più determinati nelle nostre decisioni.
La vera dimora di Cristo che i due discepoli chiedono non è una casa fisica, per altro Gesù non disponeva neppure di un cuscino dove posare il capo (cf. Lc 9, 58), ma la sua relazione col Padre. È questa la dimora che i discepoli chiesero di conoscere e dove domandarono di entrare. I discepoli cercavano dove sta di casa la Parola; chiedevano la luce della loro vita. Solo lì essi sono a casa. Andare a Gesù significa aderire a lui per partecipare della sua relazione col Padre e condividere la sua stessa vita divina. Ecco il senso dello “stare con lui”. Egli ci invita a partecipare per essere anche noi là dove lui da sempre è: presso il Padre. La vera dimora di Gesù è la sua comunione col Padre, come ha saputo esprimere in modo emblematico sant’Agostino: “Il nostro cuore è inquieto, finché non riposa in te” (Confessioni, 1, 1.5).
In questo senso il “vedere” a cui Gesù li invita non è solo azione dell’occhio fisico, ma soprattutto di quello interiore. È un vedere illuminato dalla luce dello Spirito che fa dischiudere il senso della Parola. L’atto del vedere in Giovanni è inscindibilmente unito a quello dell’ascolto. Vedere e ascoltare si completano a vicenda. L’uno richiama l’altro. Dalla loro unità scaturisce l’intelligenza spirituale, che elabora tutti i dati provenienti dalla conoscenza fisica, intellettuale, spirituale, mistica. Si tratta di una serie di registri che si intersecano tra di loro in dissolvenza. È grazie ad essi che il credente compie il delicato passaggio della fede, attraverso il quale ha modo di vedere in Gesù il Cristo, come lascia intendere nei racconti delle apparizioni, quando entrando nel sepolcro con Pietro “vide e credette” (Gv 20, 8). Si tratta dunque di un vedere che fa sfociare la ricerca nella fede. A questo sguardo i discepoli vengono educati da Cristo dopo la sua risurrezione. Egli, con le sue apparizioni, li abitua a vedere la sua forma gloriosa. In verità questo è uno sguardo a cui i Vangeli accennano già durante l’esperienza della vita terrena di Gesù, come l’episodio di Pietro, quando a Cesarea di Filippo intuisce per la prima volta, nella persona di Gesù, la presenza del Cristo (cf. Mt 16, 15-20). Il “Venite e vedrete”, di cui parla il Vangelo, costituisce l’invito rivolto a chiunque si pone alla ricerca di Cristo, una ricerca che si compie nella conoscenza, che l’evangelista esprime in termini di dimora. Dimorare insieme a Cristo è avere la stessa vita, vivere nell’unica comunione d’amore. Vedendo e ascoltando i discepoli capiranno: “io sono nel Padre e voi in me ed io in voi” (Gv 14,20).
La contestualizzazione di questo brano nel nostro orizzonte storico ci consente, dunque, di cogliere in profondità il passaggio spirituale al quale siamo, più che mai, chiamati nell’oggi ecclesiale e sociale. L’incontro con Gesù determina in questi due discepoli il passaggio da una spiritualità, che potremmo definire di tipo monacale e individuale, quale è appunto quella del Battista e volendo anche quella che si è andata definendo ed affermando in questi due millenni di storia cristiana, ad una spiritualità comunitaria e più specificamente ecclesiale; consente loro di entrare in comunione ed interagire con una rinnovata visione di Dio, pensato fino ad allora in termini di uno e compreso ora in termini di relazione trinitaria. Qui è la scoperta più rivoluzionaria che ha dato modo ai due discepoli di rimanere presso Gesù per tutta la loro vita. Qui è, a mio avviso, anche l’intuizione più autentica che può dare origine ad una rinnovata conversione spirituale della fede cristiana nel futuro ecclesiale e sociale.
La prospettiva biblico-spirituale, dunque, può aiutarci a cogliere il senso di quei ‘segni dei tempi’ che possono rivelarsi appena percettibili, esattamente come quelli che si presentarono ad Elia sul monte Carmelo, all’indomani della crisi spirituale che scoppiò in lui, a seguito della minaccia di morte della regina Gezabele (cf. 1Re 19, 12ss), segni che necessitano da parte nostra di una maggiore sensibilità spirituale, capace di registrarne la presenza nell’oggi della fede e che richiedono, al contempo, gesti piccoli e profetici, come i granelli di senape di cui parla Gesù (cf. Mt 13, 31-32), piccoli e sillabici come il sì di Maria, ma capaci di originare una nuova epifania spirituale in Europa.



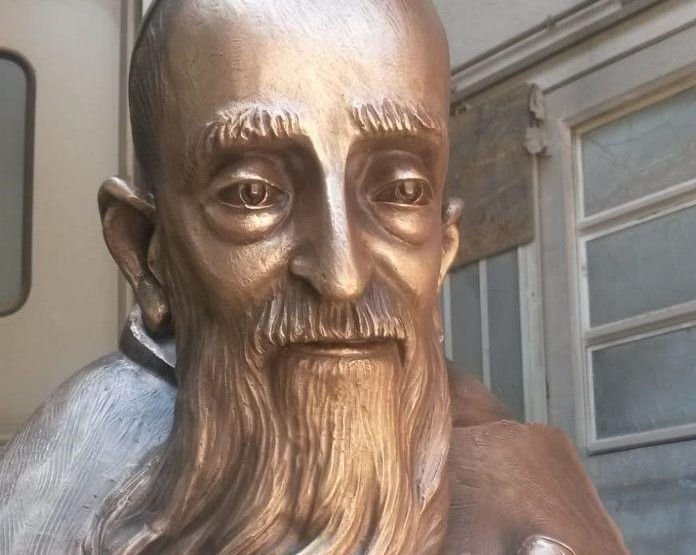
Bella e ampia riflessione che spazia tra il concetto di una Europa nuova fondata su principi autentici di cristianità e più in generale sull'essere oggi cristiani nell'era del relativismo assoluto e dell'individialismo già tempo fa ebbi modo di riprendere in un'articolo sul giornale la roccia le idee su un Europa cristiana di sua eccellenza mons. Verolino e ora ampiamente e magistralmente trattata da don luigi razzano!
Bella e ampia riflessione che spazia tra il concetto di una Europa nuova fondata su principi autentici di cristianità e più in generale sull'essere oggi cristiani nell'era del relativismo assoluto e dell'individialismo già tempo fa ebbi modo di riprendere in un'articolo sul giornale la roccia le idee su un Europa cristiana di sua eccellenza mons. Verolino e ora ampiamente e magistralmente trattata da don luigi razzano!