30 Maggio 2021 - Santissima Trinità Anno B
- don luigi
- 30 mag 2021
- Tempo di lettura: 11 min
Dt 4, 32-34.39-40; Sal 32/33; Rm 4, 14-17; Mt 28, 16-20
La Trinità:
principio e fondamento della nuova logica relazionale
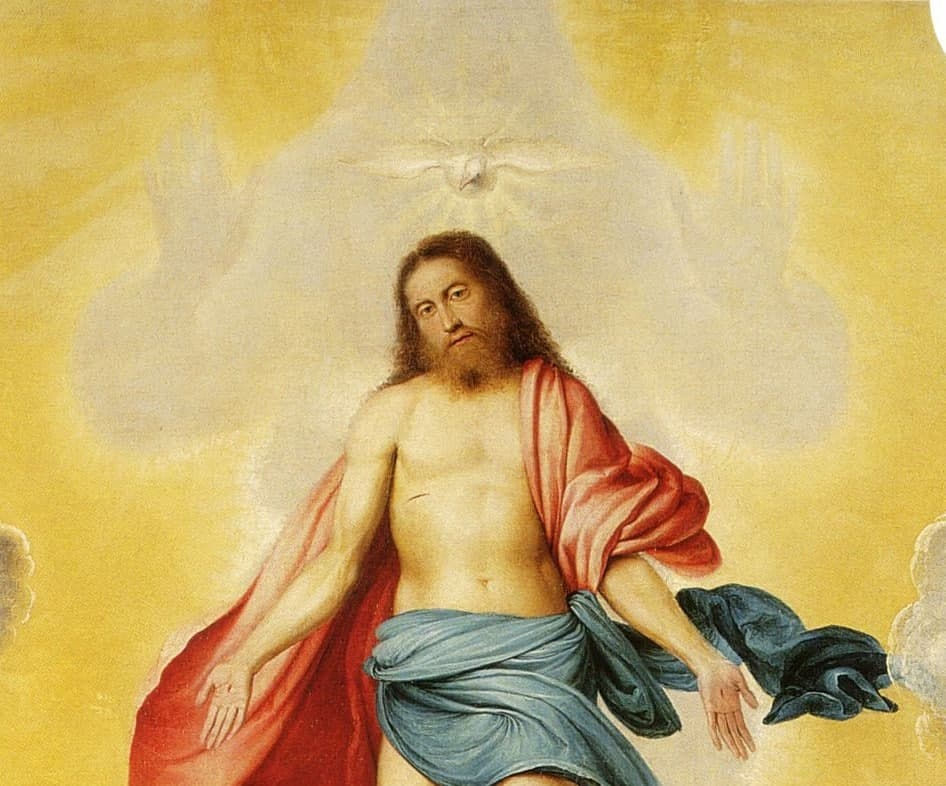
Nella domenica immediatamente dopo la Pentecoste la Chiesa ci fa celebrare il mistero trinitario di Dio. Si tratta di uno dei dogmi[1] più misteriosi e inaccessibili alla nostra intelligenza. Forse il dogma per eccellenza. In ogni caso quello che più di tutti sfida la nostra ragione con la logica divina di un amore comunionale che sfugge ad ogni tentativo di inquadramento intellettivo[2]. Consapevoli di trovarci dinanzi ad una realtà così abissale, lasciamo per il momento agli studiosi il compito di svolgere un’indagine speculativa e sistematica, sotto l’aspetto teologico[3], per sforzarci invece di capire le conseguenze che una simile prospettiva di vita relazionale comporta per la nostra vita umana[4]. Per farlo ritengo importante meditare su quella realtà dell’amicizia, promossa e vissuta da Gesù nei suoi rapporti interpersonali con i discepoli, come condizione fondamentale per accedere alla sua conoscenza di Dio e alla dimensione filiale della sua identità. Vi chiedo perciò di non limitarvi solo a leggere, ma a meditare su questo aspetto della vita di Gesù, sforzandovi di creare quei presupposti che consentono a Cristo di ripetere anche a noi, oggi, ciò che disse ai suoi discepoli: “Voi siete miei amici” (Gv 15,14). L’amicizia costituisce perciò la condizione più profonda e autentica che consente a Gesù di aprire il suo cuore, per esternare i sentimenti che scaturivano dalla sua intima relazione col Padre, al contempo, a noi di partecipare della sua comunione d’amore col Padre, nello Spirito.
Naturalmente l’amicizia di Gesù è espressiva di quel vissuto evangelico che lascia intravedere la sua relazione con Dio e quindi la dinamica della vita trinitaria dalla quale egli proviene. In questa prospettiva perciò vi propongo di tenere come sfondo biblico per la vostra meditazione anche alcuni significativi episodi della vita di Gesù, come il Battesimo (cf. Mc 1,9-11 e //) e la Trasfigurazione (cf. Mt 17,1-8 e //), dove, sia pure implicitamente, si fa riferimento alla realtà trinitaria e, quindi al mandato battesimale di Cristo (cf. Mt 16, 19), nel quale il riferimento trinitario appare più chiaro.
Interessante si rivela anche la collocazione del mistero trinitario in questo tempo dell’anno liturgico, a ridosso cioè della Pentecoste e della Risurrezione, come a voler dire che solo chi ha fatto esperienza della potenza risorgiva di Dio, della passione e redenzione di Cristo e della forza carismatica dello Spirito, può giungere a farsi un’idea di quell’amore che accomuna Dio nell’unità della sua realtà divina, nel mentre lo distingue col carattere specifico delle relazioni personali.
Premesso ciò, riprendiamo ancora una volta il Discorso di Addio. Tra le promesse che Gesù fa durante questo discorso c’è quella dello Spirito dell’intelligenza (cf. Gv 14,17.26; 16,13-15) che dovrà guidare i discepoli a comprendere il mistero della verità, in tutta la sua interezza o, come dice Giovanni, alla “verità tutta intera” (Gv 16,13). Nelle ultime due domeniche abbiamo avuto modo di capire che la “verità” di cui parla Gesù non si riduce ad un concetto astratto, ma è intrinsecamente caratterizzata da una dimensione relazionale che rimanda direttamente a quella che lui intesse col Padre, nel vissuto quotidiano dell’amore evangelico. La verità è il principio creativo e vitale da cui ogni cosa ha origine ed esistenza, perciò essa ha a che fare direttamente con Dio-Padre, presso il quale lui dimora e dal quale proviene (cf. Gv 1,1-3). Si tratta dunque di una verità conoscibile non tanto da coloro che sono dotati di una capacità intellettiva, speculativa e razionale, ma principalmente da quelli che, come Pietro a Cesarea di Filippo, si dispongono ad essere resi partecipi della rivelazione del Padre (cf. Mt, 16,17). Solo chi entra nella relazione evangelica con Gesù ed è guidato interiormente dal ‘canone dell’amore’[5], ha accesso alla verità. Costui viene reso partecipe dello stesso dinamismo relazionale che sussiste tra Gesù e il Padre. Ed è alla luce di questo vissuto d’amore evangelico che si ha modo di gettare uno sguardo nell’abisso di quella verità che Dio tiene nascosta ai sapienti e rende oscura e impenetrabile agli intelligenti di questo mondo, ma rivela ai piccoli evangelici. L’Inno di giubilo di Gesù (cf. Mt 11,25-27), diventa così la chiave interpretativa e di accesso al mistero della verità divina: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,27). Gesù rivela la conoscenza che lui ha del Padre solo a chi è disposto a intessere con lui un rapporto di amicizia (cf. Gv 15,14-15). È facendo memoria di questa relazione e di questo insegnamento che i discepoli, alla luce della sua Risurrezione (cf. Gv 20,11-29) e per mezzo del dono dello Spirito (cf. At 2,1-13), cominciano a penetrare gradualmente il mistero della sua identità, a cogliere la sua origine divina e quindi la sua stretta relazione con Dio, come lascia intendere la formula con la quale Gesù stesso, al momento della sua Ascensione al Cielo, invia gli apostoli nel mondo a battezzare: “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). Una formula questa che diventa preludio a quell’epilogo teologico al quale gli apostoli – e in modo particolare la generazione dei Padri che succede a loro – giungono solo al termine di un lungo processo riflessivo, durante il quale sono stati guidati e accompagnati dallo Spirito, come promesso da Gesù (cf. Gv 16,12-15). È a partire da questa comprensione che comincia gradualmente lo sviluppo di quella riflessione teologica che condurrà successivamente a qualificare il mistero di Dio in termini trinitari[6]. È chiaro dunque che per chi si accingesse a voler cercare e trovare, nei testi sacri, in modo esplicito, la formula trinitaria di Dio, rimarrebbe profondamente deluso, in quanto essa è una formula teologica più che evangelica e fa parte, probabilmente, di quel contenuto che diviene comprensibile solo grazie ad un’intelligenza matura, che gli apostoli evidentemente non erano ancora in grado di capire e portarne il peso (cf. Gv 16,12), tanto innovativa era la verità ad essi rivelata da Gesù.
Quella verità, dunque, che a livello neotestamentario è presente solo a mo’ di intuizione spirituale comincia ad essere sviscerata ed esplicitata grazie alla speculazione teologica dei Padri che l’hanno formulata anche sotto l’aspetto dogmatico. È in questo stesso orizzonte teologico ed ecclesiale che anche noi ci introduciamo per accedere al mistero trinitario di Dio. Pertanto noi non siamo né i primi né gli ultimi ad accostarci ad esso, ma facciamo parte di quel grande piano d’amore salvifico del Padre, che Gesù è venuto a svelarci attraverso lo Spirito. La vita evangelica che Gesù conduce tra gli uomini ci offre dunque uno spaccato su quella trinitaria dalla quale proviene. La relazione filiale che lui intesse col Padre, durante la sua vita terrena, ci lascia intravedere quella originaria e divina, nella quale lui da sempre ha vissuto e dimorato. Fuori da questo suo orizzonte evangelico è praticamente impossibile percepire e intendere la profondità del mistero trinitario che lo costituisce. Egli più che argomentare la sua origine trinitaria l’ha lasciata vedere con la testimonianza della vita relazionale con gli uomini. Il suo vangelo diventa così la manifestazione visibile della vita trinitaria. Dal modo con cui si relaziona alle persone, si capisce la dinamica della relazione trinitaria che lo costituisce. La testimonianza di questa vita divina diventa così evidente che, parafrasando un suo detto, potremmo dire che: vederlo vivere il vangelo, significa vedere la vita trinitaria (cf. Gv 14,9). Il suo vangelo altro non è che la vita trinitaria sulla terra. Gesù con la sua vita evangelica ci rivela la dinamica relazionale che caratterizza la vita trinitaria, pertanto vivere evangelicamente significa vivere le relazioni umane all’insegna di quelle trinitarie. Ecco la nuova dinamica relazionale che egli inaugura tra le persone. Pertanto il battesimo, che lui chiede agli apostoli di estendere a tutti i popoli (cf. Mt 28,19), non si riduce ad un semplice rito religioso, ma diventa un processo di iniziazione alla vita trinitaria, a partire dal quale la dinamica della sua vita divina viene estesa a tutta la vita del mondo. Ed è entrando in questa nuova dinamica relazionale che lo Spirito promesso da Gesù predispone la nostra intelligenza alla conoscenza della paternità di Dio, della sua filialità divina e quindi della nostra filialità adottiva, secondo le parole che Paolo rivolge ai Romani: “Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba! Padre” (Rm 8,15). Infatti è lo Spirito stesso che attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio (cf. Rm 8,16). E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo” (Rm 8,17). Senza lo Spirito nessuno può rivolgersi a Dio e chiamarlo Padre. È lui che ci informa sulla paternità di Dio e ci abitua a relazionarci a lui in termini filiali. Egli ci rende partecipi della stessa eredità filiale di Gesù. Attraverso lo Spirito Gesù sembra così dischiude quel tesoro di sapienza, al quale fa riferimento Paolo nella sua lettera agli Efesini: “Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente e farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi credenti” (Ef 2,17-19).
Per quanto diffuso e comune questo linguaggio filiale e paterno, proprio della fede cristiana, non è da considerarsi affatto scontato. La filialità di cui parla Paolo non viene acquisita in virtù di una generica dimensione religiosa, ma principalmente grazie alla relazione di fede in Cristo. Noi diveniamo figli di Dio solo se riconosciamo e crediamo Gesù Figlio di Dio e siamo disposti a vivere le nostre relazioni interpersonali secondo il comandamento dell’amore reciproco (cf. Gv 15,4-17). È partecipando di questa sua relazione filiale ed evangelica che anche noi diveniamo figli nel Figlio. Un mistero questo che come ribadisce ancora san Paolo nella lettera ai Corinti: rimane nascosto al percorso sapienziale e alla logica conoscitiva dei dominatori di questo mondo, ma che Dio svela, per mezzo del suo Spirito, ai cuori di coloro che lo amano, a noi dunque che abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato (cf. 1Cor 2,3-12). “Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio” (1Cor 2,10). La relazione filiale di Cristo e quella paterna di Dio, vissute nella comunione reciproca dello Spirito, vengono formulate con un linguaggio che si presta ad un’interpretazione trinitaria. Ciò non esclude che la verità che esso dischiude alla nostra intelligenza necessiti di un approfondimento teologico, che senza scadere in un razionalismo tecnico ed astratto, mantenga sempre viva quella realtà di comunione trinitaria come, ancora una volta, emerge da questa mirabile sintesi di teologia paolina: “La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi” (2Cor 13,13), che diviene formula dei suoi saluti epistolari e delle nostre celebrazioni liturgiche.
La conoscenza di Dio che gli amici ricevono da Gesù non è di tipo nozionistico, quella cioè che consente di avere solo un’idea parziale della realtà di Dio, ma integrale che apre ad una partecipazione viva e vera della vita di Dio. Il Dio di cui parla Gesù non è un’idea da pensare, ma un Padre con cui relazionarsi. Occorre perciò amarlo come lui lo ama per ereditare la sua stessa relazione filiale. La sua amicizia e la sua filialità divina diventano così le condizioni e il luogo che consentono di gustare, vivere e rimanere in quella relazione di comunione con lui, tanto auspicata da Gesù e continuamente ribadita da Giovanni: “rimanete nel mio amore” (cf. Gv 15,4-11).
L’amicizia costituisce anche la realtà che più di tutte ci consente di comprendere la particolare relazione che Yhawhè (il nome con cui Dio viene riconosciuto da Mosè e dal popolo ebraico a partire dalla rivelazione del monte Sinai), intende creare col suo popolo. Non si tratta di una relazione di tipo morale e dottrinale, come spesso avviene nelle varie esperienze religiose, ma di un rapporto che coinvolge in prima persona Dio e il fedele. Nello specifico, la fede ebraica si distingue dalle altre esperienze religiose, per la particolare rivelazione personale che Dio fa di sé e della sua volontà salvifica, intima e profonda, come vera e universale. Egli non intende salvare costringendo i fedeli ad osservare rigidamente tutte le norme dottrinali che scaturiscono dalla sua rivelazione, come sembrano lasciare intendere le disposizioni religiose mosaiche, ma principalmente attraverso una partecipazione della propria esperienza d’amore. È questa l’intenzione fondamentale che sta all’origine della rivelazione divina. Il brano biblico della prima lettura, tratto dal libro del Deuteronomio, pone in risalto la domanda con la quale Mosè cerca di far prendere coscienza al popolo di questa specifica intenzione di Dio (cf. Dt 4,39). Essa mette ciascuno dinanzi alla responsabilità di essere il diretto referente di Dio, col quale egli intende interagire e stabilire un rapporto di reciproca fiducia, invitandolo a considerare attentamente i segni con i quali Dio interviene nella sua vita personale e comunitaria (cf. Dt 4,32-34). Se c’è una ragione che spinge Dio a stabilire leggi per il suo popolo, questa è da individuare esclusivamente nel desiderio divino di vedere il suo popolo felice (cf. Dt 4,40). È qui dunque la specifica intenzione di Dio che fa luce sul desiderio più autentico e profondo che egli nutre per ciascuno di noi: “perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te”. Come non cogliere in questa intenzione di Dio anche quella di Cristo: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11). Gesù ci rivela la sua amicizia per renderci partecipe della gioia che scaturisce dalla vita della sua comunione trinitaria. Auguro a ciascuno di voi di diventare un amico di Cristo, per gustare la pienezza della sua “verità tutta intera, rimanendo nella delizia del suo amore (cf. Gv 15,9).
[1] Dogma deriva dal termine greco dogma-atos che letteralmente significa “decreto, decisione”. Si tratta di un termine che viene utilizzato per indicare un principio fondamentale o una verità universale, proveniente da un’esperienza religiosa o da una convinzione filosofica, posta alla base della loro dottrina, ritenuta e creduta vera, non soggetta a dubbi e a discussioni da parte dei fedeli. Nello specifico, la teologia cristiana attinge tale verità direttamente dal vissuto evangelico, dalla conoscenza e dalla testimonianza rivelativa di Cristo. Spesso, nell’opinione comune, tale termine viene considerato come l’enunciato di una verità che va accettata ciecamente, senza l’ammissione di alcuna forma di argomentazione o tentativo di conoscenza speculativa. Al contrario nella storia della teologia si assiste ad un suo sviluppo cognitivo, pur senza dubitare della sua vericità. Il suo contenuto perciò viene compreso a secondo della maturità intellettiva e della partecipazione alla vita divina di Dio, in Cristo. [2] Significativa a questo riguardo è la metafora agostiniana del bambino sulla spiaggia: “Un giorno sant’Agostino in riva al mare meditava sul mistero della trinità, volendolo comprendere con la forza della ragione. Vide allora un bambino che con una conchiglia versava l’acqua del mare in una buca. Incuriosito dall’operazione ripetuta più volte, Agostino interrogò il bambino chiedendogli: “Che fai?”. La risposta del fanciullo lo sorprese: “Voglio travasare l’acqua del mare in questa mia buca”. Sorridendo sant’Agostino spiegò pazientemente l’impossibilità dell’intento ma, il bambino fattosi serio, replicò: “Anche a te è impossibile scandagliare con la piccolezza della tua mente l’immensità del mistero trinitario”. E detto questo sparì. [3] Per indagine speculativa e sistematica della teologia intendiamo quella ricerca che nella Chiesa viene svolta in modo particolare dai teologi, il cui compito è quello di dare ragione della verità di fede a quanti cercano di comprendere il mistero anche sotto l’aspetto razionale. [4] Ed è a questo livello che, oggi, urge la necessità di riconsiderare e approfondire la dinamica della vita trinitaria. L’individualismo, al quale ci ha abituato la cultura moderna e contemporanea, ha reso così sterile e inefficace questa prospettiva di vita trinitaria di Gesù che ha indotto uno dei più noti teologi del XX secolo a dire che: se per ipotesi il dogma della trinità dovesse essere escluso dalla dottrina della fede cristiana i cristiani neppure se ne accorgerebbero, tanto ininfluente e nella loro mentalità (K. Rahner). [5] L’espressione ‘canone dell’amore’, viene intesa come “regola” (dal greco kanon-onos) che ha l’amore (e non solo la ragione) come guida dell’intelligenza e criterio di verifica della verità. [6] Sotto l’aspetto cronologico il primo a coniare il termine latino “Trinità” è stato Tertulliano (155 circa – 230 circa), nel suo De pudicitia, anche se prima di lui Teofilo di Antiochia (+ 183/185) utilizzò un termine greco analogo “trias” nel suo Apologia ad Autolycum. La dottrina trinitaria venne poi meglio precisata prima nel Concilio di Nicea (325) e poi in quello Costantinopolitano (381).




Commenti