17 Settembre 2023 - Anno A - XXIV Domenica del Tempo Ordinario
- don luigi
- 16 set 2023
- Tempo di lettura: 9 min
Aggiornamento: 20 set 2023
Sir 27,30-28,7 (gr. 27,30-28,7); Sal 102/103; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Il perdono: la legge della libertà

“Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18,21-22);
“Perdona l’offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati” (Sir 28,2).
“Benedici il Signore, anima mia … egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità” Sal 102/103,1.3).
Dopo la correzione fraterna la Liturgia della Parola ci propone un’altra pratica fondamentale: il perdonovicendevole. Come la correzione anche il perdono è parte integrante della vita spirituale, anzi costituisce il segno più distintivo ed esplicito della vita evangelica. Correggere e perdonare sono due pratiche strettamente connesse. Non è possibile praticare l’una senza l’altra. Chi corregge non si limita a biasimare il prossimo, ma a perdonare anche i suoi peccati o errori. D’altra parte, chi perdona non si riduce a sopportare i suoi limiti, ma a trovare anche le occasioni per correggerlo, secondo le disposizioni di Cristo, di cui abbiamo parlato domenica scorsa (cf. Mt 18,15-20).

Ancora una volta il protagonista è Pietro. È lui ad offrire a Gesù l’occasione per esporre il suo insegnamento sul perdono. E ancora una volta la sua perplessità ci dà modo di fare chiarezza sui pregiudizi e sulle difficoltà che anche riscontriamo in merito al perdono. Stando all’attuale traduzione del brano evangelico l’equivoco di Pietro, nel quale molto spesso anche noi cadiamo, è quello di considerare la pratica del perdono come un dovere morale: “quante volte devo perdonare?”, quando invece per Gesù esso costituisce la manifestazione libera dell’amore: “non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”. Pietro, con la sua domanda, pensava di portare all’estremo l’amore di Gesù verso il prossimo, e invece Gesù gli chiede di spingersi fino all’estreme potenzialità divine che sono in lui. Gesù esige il perdono non per assoggettare Pietro al suo insegnamento dottrinale, ma per educarlo ad amare come ama Dio. Il suo non è un imperativo di tipo morale o giuridico, col quale intende imporre la sua volontà o limitare la libertà di Pietro, vincolandolo a una legge, ma una condizione spirituale per indurlo alla pienezza dell’amore evangelico. Chi perdona, infatti, è segno che eccede nell’amore. Pertanto solo chi ama perdona e lo dona con gratuità e generosità; chi invece lo avverte e lo esercita come un obbligo morale tollera. Può sembrare un paradosso, ma il perdono è il “comandamento” divino che rende l’uomo pienamente libero di essere se stesso. Perdonare, allora, significa amare come Dio, in modo illimitato e traboccante e mettere l’altro nella condizione di ricominciare.

La domanda di Pietro, tuttavia, più che riferirsi a questa estrema manifestazione d’amore, tipicamente evangelico, sembra riguardare quelle situazioni quotidiane, dove solitamente sperimentiamo la fatica del perdono, specie nei confronti di coloro che intessono con noi relazioni di tipo familiare, amicale, affettive, lavorative, ecclesiale insomma tutti coloro che non consideriamo direttamente nemici, ma che comunque, in diverse occasioni, si comportano come tali: con offese gratuite, sentimenti di invidia, di rabbia, rancore, disistima, sfiducia. Coloro che non perdono occasioni per ostacolare le nostre scelte, vincolarci alle loro decisioni, sminuire le nostre idee, impedire lo sviluppo delle nostre qualità, della nostra personalità e quant’altro. Tutte situazioni che rendono difficili, e talvolta insostenibili, le relazioni interpersonali. Situazioni in cui il perdono non viene praticato una tantum o in modo occasionale, ma necessita di essere offerto frequentemente e dove il rischio più forte è quello di sminuirne il valore. È qui che si sperimenta la fatica del perdono.

È qui che si comprende la domanda di Pietro: “Quante volte?”. Come a dire: se il mio prossimo persiste nella sua ostinazione, senza manifestare alcuna forma di pentimento, anzi mostrandosi sordo e cieco a qualsiasi manifestazione d’amore, “quante volte” devo perdonarlo? “Quante volte”, per esempio, va perdonato chi persevera consapevolmente e volontariamente nel peccato, sottraendosi a qualunque tentativo di correzione? O a chi, in ambito matrimoniale e familiare, si sottrae costantemente a tutte le forme di responsabilità? O ancora a coloro che, come gli abusatori seriali, vivono queste situazioni regolarmente? Acoloro che esercitano sistematicamente la politica per fini economici, finanziari, sfruttamento etnico, anti ecologici? A chi perfino strumentalizza Dio, la Chiesa, il sacerdozio, il prossimo per affermare se stesso, le proprie idee, ed esercita il proprio ruolo ecclesiale come forma di dominio sociale?
Si tratta, com’è evidente, di situazioni per nulla accidentali o legate solo alla fragilità umana. Al contrario, esse sono l’espressione di una struttura di peccato, sistematicamente organizzata, espressione di una mentalità culturale che ha perso o esclude qualsiasi riferimento morale o religioso. Si tratta sì di casi limiti – anche se purtroppo sempre più diffusi– ma che ci fanno capire che il perdono lungi dall’essere dato per scontato, necessita invece di un percorso educativo e formativo per essere praticato.

Da qui alcune domande che possono stimolare la nostra riflessione. Cos’è il perdono? Perché perdonare? Perché è così difficile esercitarlo? Come progredire in esso? Quali sono i luoghi o le circostanze per imparare a praticarlo? Il perdono è l’espressione più matura dell’amore, per cui perdona solo chi si esercita nell’arte dell’amore. Solo chi dispone di un’eccedenza d’amore è in grado di donarlo all’altro. Da qui il significato di per-dono, ovvero dono per l’altro. Pertanto non si perdona per quieto vivere, ma per elargire con larghezza di cuore l’amore che Dio nutre per noi.

La difficoltà che sperimentiamo nel praticarlo dipende molto spesso da una nostra incapacità d’amare. Chi, per esempio, fa già tanta fatica ad amarsi è chiaro che non può pretendere di amare l’altro. Chi nutre un’eccessiva attenzione verso il proprio io rivela una naturale indisposizione verso l’io dell’altro. L’egoismo, l’egocentrismo sono segnali di una reale difficoltà a crescere nella relazione d’amore con l’altro. Ciò si manifesta quando – come afferma san Paolo – viviamo e moriamo per noi stessi, ovvero quando agiamo e pensiamo in vista della nostra individualità (cf. Rm 14,7). Il perdono invece prevede l’apertura all’altro e la reale disposizione ad accoglierlo nella propria vita. Ma in un contesto sociale come il nostro che promuove il sospetto, la sfiducia, la diffidenza verso l’altro e dove la spiritualità cristiana viene spesso ridotta a una prassi culturale, allora più che mai si avverte l’urgenza di tracciare percorsi formativi che educhino ad amare e dove il perdono non costituisce un atto eroico o straordinario d’amore evangelico, ma viene praticato come un gesto quotidiano, proprio della relazione umana, all’interno della quale ciascuno può godere sempre di una speranza di redenzione per ricominciare. Non è forse questa la ragione per cui Gesù chiede di “perdonare settanta volte sette?”. Per lui, allora, ogni relazione interpersonale costituisce un pretesto per imparare ad amare e a perdonare. Pertanto la quotidianità costituisce la prima scuola d’amore. L’amore, infatti, non è una qualità innata che porta istintivamente ad essere tutti buoni. Esso non è affatto un deposito di bontà di cui si dispone naturalmente.

Ad amare s’impara amando. Allo stesso modo a perdonare s’impara perdonando. In essi si cresce e progredisce come in tutte le discipline umane. Il suo percorso è costellato perciò di conquiste e fallimenti, di atti di altruismo e di egoismo, di generosità e di resistenze che non devono spaventarci né esaltarci, anche quando si manifestano in forme eccessive. Solo Dio ama sempre, perché la sua natura è intrinsecamente costituita dall’amore (cf. 1Gv 4, 8). Le persone, invece, noi, amano per partecipazione, come attesta Giovanni nella sua prima lettera: “Noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo”(cf. 1Gv 4, 19). L’amore non è originato da una volontà umana autotrascendente, ma dalla nostra risposta all’amore di Dio, sperimentato attraverso la pratica quotidiana della relazione evangelica: “Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi” (cf. 1Gv 4,10). Amare non è un atto accidentale, compiuto sull’onda di un eccesso di bontà e generosità, ma un esercizio costante, attraverso il quale siamo chiamati ad impregnare d’amore divino tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo. Fuori da questa prassi d’amore è praticamente impossibile perdonare. Pensare di farlo senza fare esperienza di questa eccedenza d’amore divino è come pretendere di scrivere un libro senza mai aver imparato l’alfabeto, o voler realizzare un’opera d’arte senza mai aver imparato a scolpire o a dipingere.

Così inteso il perdono non è l’espressione di una relazione idilliaca, una sublimazione della nostra bontà, avulsa da difficoltà e complessità, ma scaturisce da una vita evangelicamente incarnata, vissuta all’insegna di un amore liberamente scelto, maturato sulla base di una decisionepersonale. Per questa ragione esso non è mai estemporaneo, suscitato da un sentimento momentaneo, spontaneo e improvviso, ma un atto a lungo esercitato, meditato e ri-provato, sia pure attraverso continui fallimenti. Esso non mira solo all’esercizio di una virtù, tesa molto spesso ad ostentare le capacità umane, ma alla conformità all’amore di Cristo, considerato non solo come un ideale verso il quale tendere con tutto se stessi, ma soprattutto come la possibilità di essere rinnovati dall’interno, in ogni circostanza, perfino quelle moralmente più incresciose e delicate. In questo senso il perdono costituisce anche una terapia psicologica e spirituale che favorisce la rimozione di tutti quei sentimenti negativi che albergano dentro di noi come l’odio, il rancore, l’astio, l’acredine, il risentimento, lo sdegno, l’ira, la maldicenza, la calunnia, l’invidia, la vendetta i cui effetti spesso determinano uno stato di malessere permanente, che rischia di diventare cronico se non risolto in tempo. Perdonare significa allora estinguere, eliminare, recidere qualsiasi sentimento, sia pure quello più raffinato e sottile, di rivalsa, di punizione, di vendetta. Diversamente, il mancato perdono consente al “nemico” che alberga dentro di noi, di continuare ad esercitare il suo influsso e ad amplificare le conseguenze negative delle sue energie malefiche. Non basta dunque prendere coscienza del male attraverso un percorso morale, occorre giungere al perdono per spegnere i focolai del suo contagio. Solo chi giunge alla radice del peccato è in grado di guardarlo in faccia e di trasfigurarlo in amore. L’atto del perdono, perciò, non va confuso con quello della tolleranza. Il primo nasce dall’esperienza dell’amore di Dio che tutto consuma, copre, estingue (cf. 1Cor 13, 4-8); il secondo dalla capacità umana di pazientare, sopportare, resistere. Il perdono ci fa sfociare nell’infinito orizzonte della misericordia di Dio, la tolleranza rimane circoscritta nel limite dalle possibilità umane. Il perdono porta alla riconciliazione e alla libertà; la tolleranza amarcare la giustizia giuridica.
Interessanti a questo proposito si rivelano i suggerimenti proposti dall’autore del libro del Siracide, il quale lungi dal considerare l’amore una pratica mistica, alla quale mettere mano solo se ispirati dall’alto, dà tre consigli estremamente pratici, che chiunque può attuare nelle proprie relazioni quotidiane. Questi tre consigli sono: dimenticare, pregare e riflettere. Essi emergono ora in modo chiaro e ora in maniera riflessa tra le righe di un testo che sembra preludere quello del Padre nostro (cf. Mt 6,9-13). Chi dimentica riesce a guardare l’altro negli occhi, senza tener conto del male ricevuto; più facilmente e rapidamente si dimentica, più si conserva il cuore puro, capace di andare oltre ogni offesa e perfino di vedere Dio in essa. Quando tuttavia le circostanze e le offese si rivelano particolarmente gravi, allora occorre ricorrere alla preghiera, per supplicare la grazia che purifica i ricordi inquinati dal male. Solo un perdono che scaturisce da una memoria purificata dalla grazia è in grado di guarire ed essere guarita, ovvero di dare e ricevere il perdono. Chi si esercita nel perdonare gli altri si dispone ad essere perdonato da Dio. Noi siamo perdonati da lui, nella misura in cui perdoniamo gli altri (cf. Mt 18,35; 6,14-15). Tra il nostro perdono e quello di Dio sussiste perciò una connessione reciproca e inscindibile: il nostro perdono sta all’altro, come quello di Dio sta a noi. Anche noi ci scopriamo capaci di perdonare quando a nostra volta veniamo perdonati. Il perdono diventa in questo caso espressione dell’amore reciproco. Terzo consiglio per esercitarci nell’arte del perdono è imparare a riflettere sulla fine della nostra vita e quindi sulla morte. Una simile attività intellettiva ci aiuta e ridimensionare l’idea che abbiamo di noi. Non poche volte infatti la difficoltà del perdono nasce da un’idea molto alta che ci facciamo di noi stessi, spesso rivelativa di un io orgoglioso ed egocentrico, che non accetta minimamente di essere messo in discussione o corretto. Al contrario il perdono manifesta una coscienza di sé mite, umile e pura che trova solo in Dio il senso dell’offesa ricevuta.
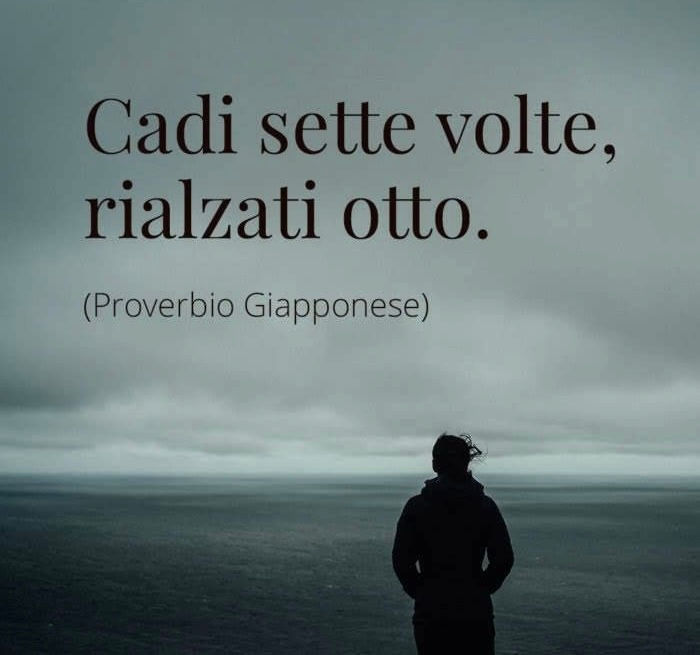
All’insegnamento estremamente pratico del Siracide fa eco quello parabolico di Gesù, che come già ha evidenziato nel caso della correzione fraterna, ci invita a creare la giusta disposizione d’animo per esercitare il perdono. I due atteggiamenti espressi dal “re” e dal “servo spietato” pertanto non fanno che esprimere in modo figurato quelli che ciascuno di noi può assumere verso chi pecca nei nostri confronti: chi ama elargisce senza misura l’eccedenza della misericordia di cui dispone, chi non ama valuta tutto e tutti secondo le strette maglie della giustizia giuridica. Chi persegue la giustizia si impegna a far rispettare le norme, affinché tutto e tutti siano conformi alla legge; chi persegue la misericordia divina guarda alla persona da promuovere. Da qui la conclusione della nostra meditazione: chi ama perdona, chi non ama giudica o al massimo tollera.




Commenti